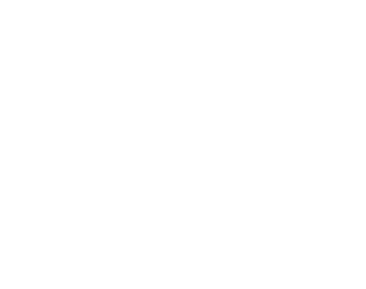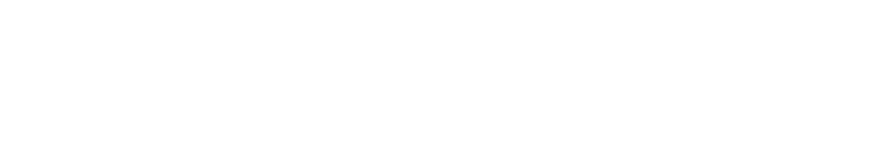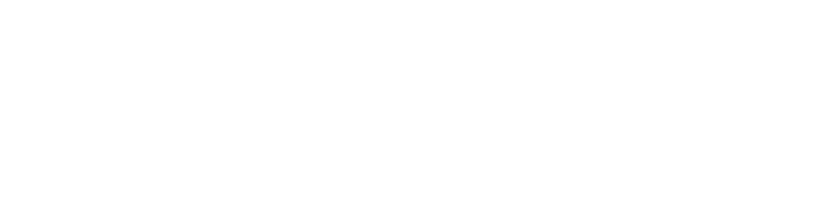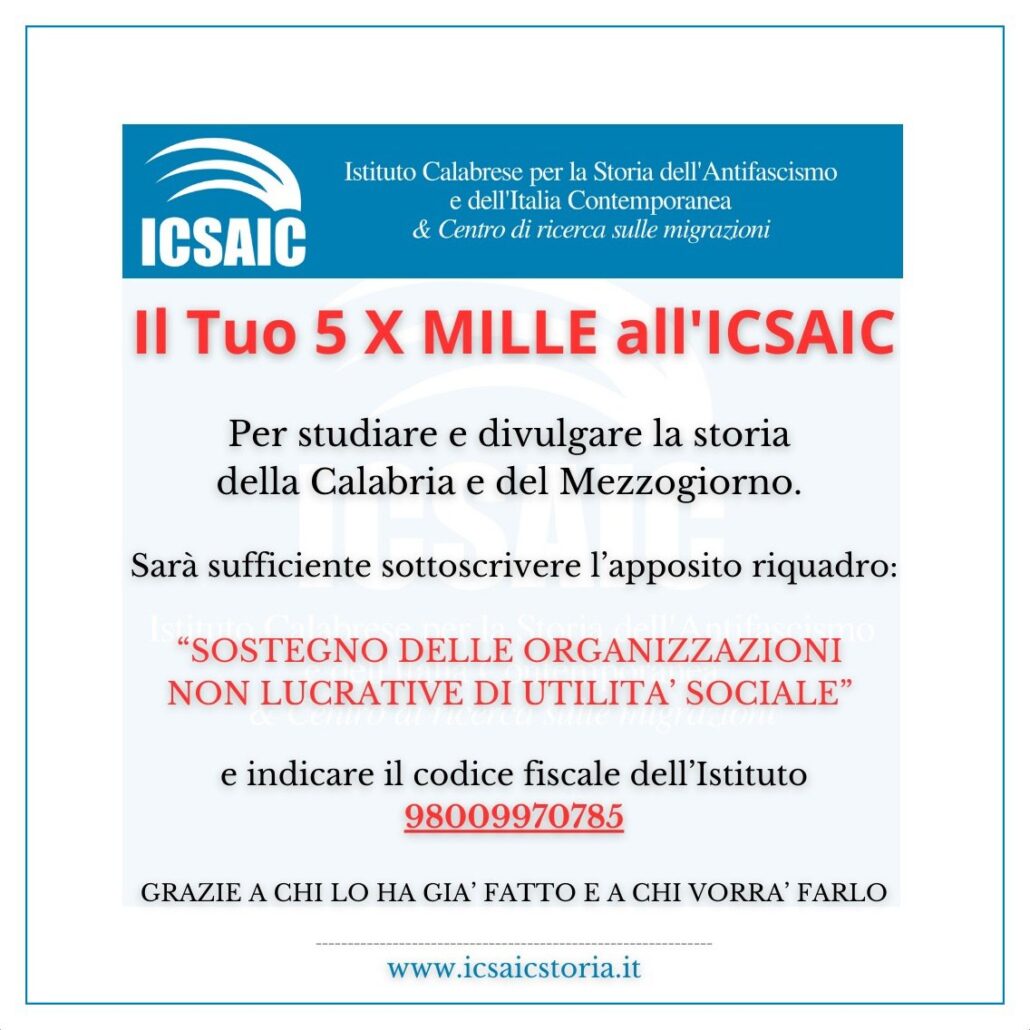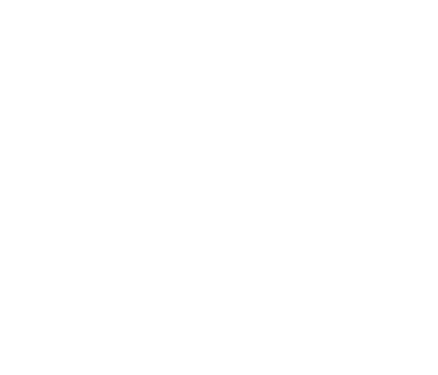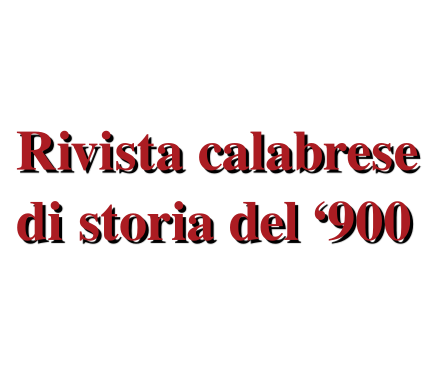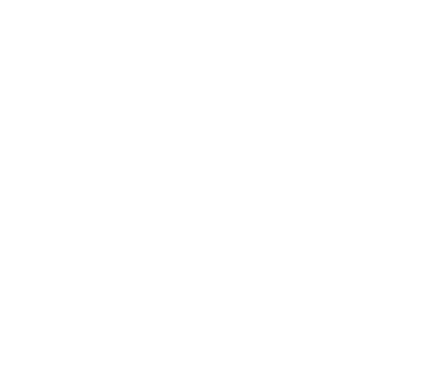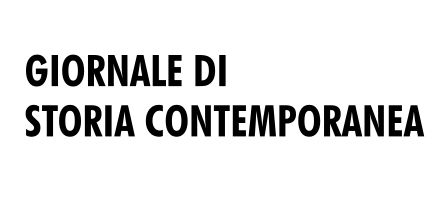Care amiche e cari amici del Dizionarioi,
Con la collaborazione essenziale di ricercatori amici procediamo a ritmi sostenuti e incrementiamo di altre dieci le voci del Dizionario Biografico della Calabria Contemporanea che ora conta 780 biografie di calabresi che hanno dato lustro alla regione. Altre biografie sono in lavorazione.
Questi i nuovi biografati e i rispettivi autori:
- Girolamo Arcovito (Domenico Coppola)
- Diego Carpitella (Massimo Distilo)
- Corrado Catenacci (Donato D’Urso)
- Saverio Gatto (Enzo Le Pera)
- Francesco Maruca (Leonilde Reda)
- Concetta Mazzullo (Rocco Liberti)
- Franco Mosino (Francesca Raimondi)
- Gaetano Repaci (Carmela Galasso, Bruno Zappone)
- Isolo Sangineto (Gabriele Petrone)
- Angelo Vaccaro (Franco Liguori)
Vi diamo appuntamento per le prossime biografie
e vi siamo grati dell’attenzione.
Buona lettura a tutti e buone ferie agostane.