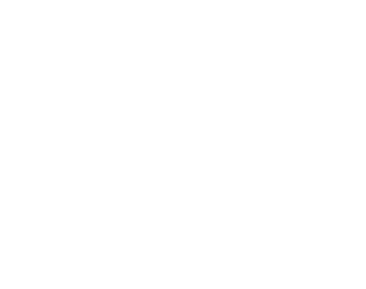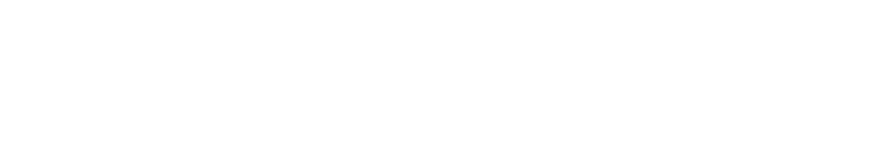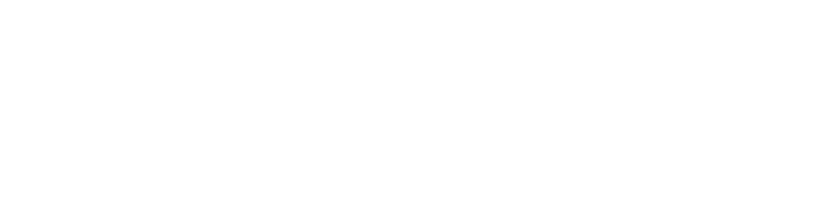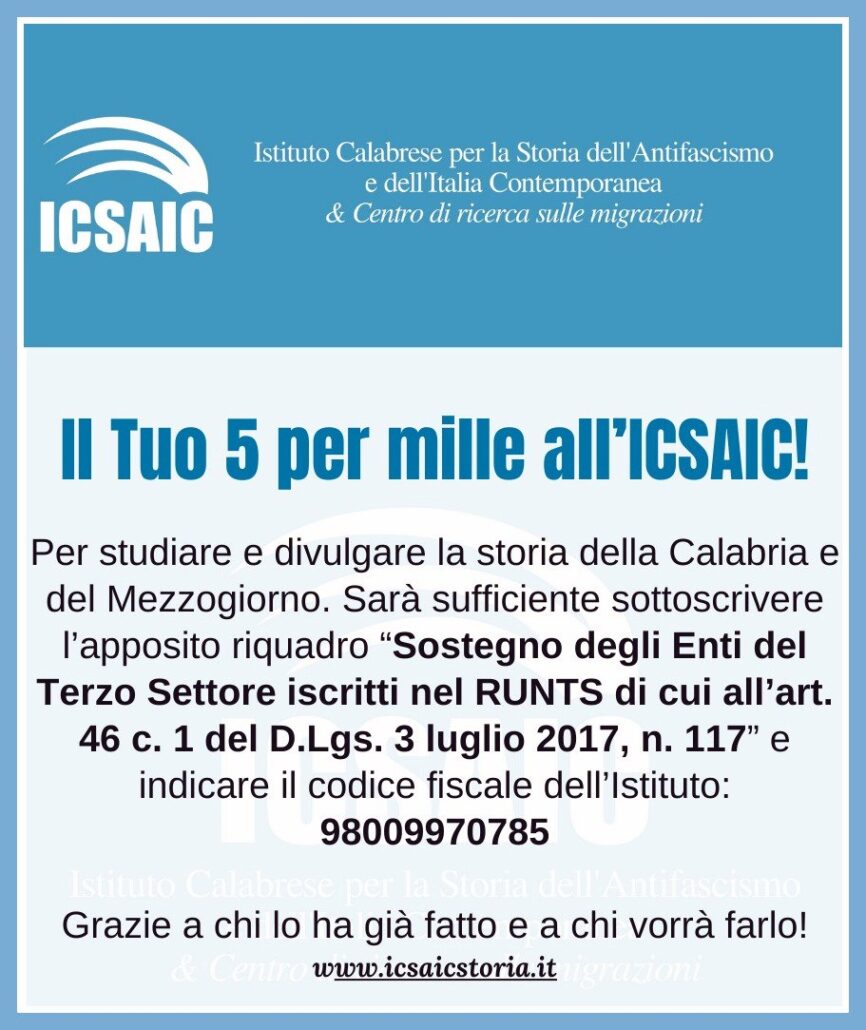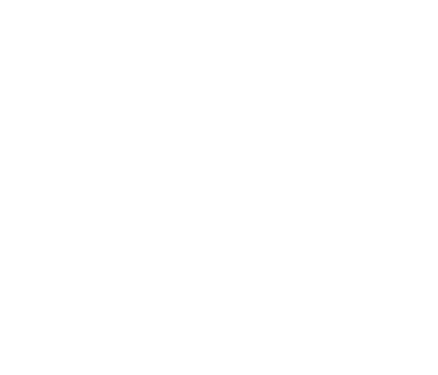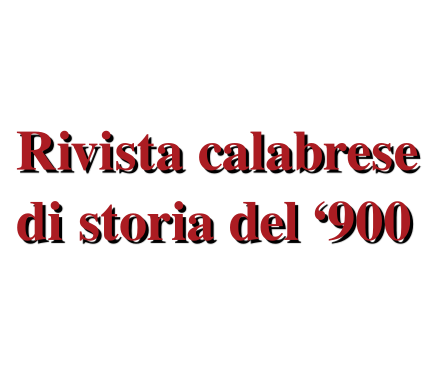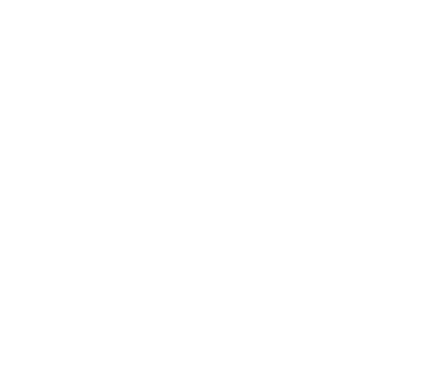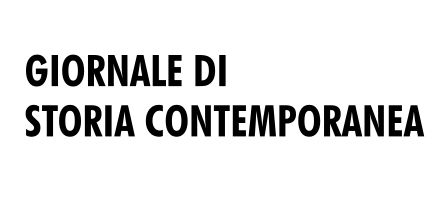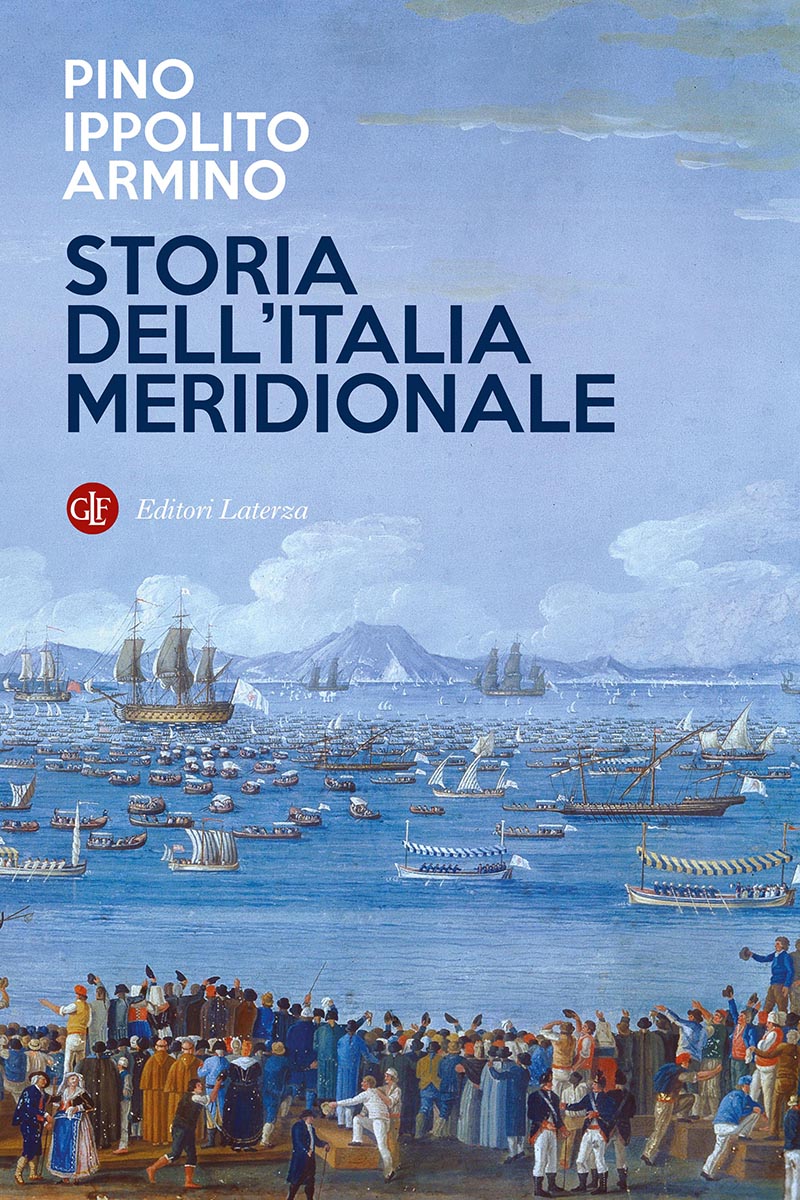
A distanza di oltre 30 anni dal Breve storia dell’Italia meridionale dall’Ottocento a oggi (Donzelli, 1993) di Piero Bevilacqua, il libro di Armino (Storia dell’Italia meridionale, Laterza 2025) si presenta come una nuova più larga sintesi, che mancava nel panorama della pubblicistica sul Sud.
L’Italia è stabilmente tra i dieci paesi con l’economia più sviluppata al mondo ma, al tempo stesso, il Meridione è l’area arretrata più estesa d’Europa. Come è dunque possibile che oltre 160 anni dopo l’unificazione ancora esista questa differenza? Questa storia dell’Italia meridionale ce lo racconta in sette snodi cruciali e il libro aiuta a conoscere e comprendere le cause dei problemi contemporanei oltre gli stereotipi e i pregiudizi. È colpa di un popolo pigro e indolente, di classi dirigenti corrotte e indifferenti o di quella che i neoborbonici chiamano ‘conquista coloniale’ del Nord? E quali sono gli avvenimenti che hanno condizionato il destino dell’Italia meridionale tanto da renderla allo stato attuale? E perché si fa fatica a invertire la rotta? Domande cruciali che aspettano da tempo una risposta.
Pino Armino, da sempre amico dell’ICSAIC, è uno storico e saggista di primo piano, autore di molti libri per varie case editrici nazionali, collaboratore tra l’altro del Manifesto, già autore per Laterza di un’apprezzata storia sul Regno delle Due Sicilie.
Intendiamoci, di storie del Regno di Napoli e anche di storie del Mezzogiorno, perfino in più volumi, ne sono state scritte non poche. La singolarità però del lavoro odierno di Armino è che esso costituisce non solo una sintesi che parte da metà ‘700 e arriva ai giorni nostri, ma riesce a dare, in poco meno di 300 pagine, un quadro di grande ricchezza e completezza della storia secolare di questa parte d’Italia.
Il Sud – come è arcinoto – gode di una letteratura sterminata, accumulatasi soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, ma essa è quasi sempre focalizzata nell’esame dello squilibrio con il Nord d’Italia. Nel libro di Armino, all’annosa questione è dedicato, con approcci peraltro originali, lo spazio che merita, ma il Sud è raccontato nel suo svolgimento autonomo oltre che, ovviamente nei suoi nessi con la storia nazionale e generale. Il volume ha poi un altro merito: quello di inserire nella vicenda meridionale anche la storia della Sardegna tra la tarda età moderna e quella contemporanea – solitamente espunta dalle ricostruzioni meridionalistiche – ma soprattutto è in grado di tenere insieme, in un racconto organico e con una scrittura di chiarezza esemplare, tutti gli aspetti e i fenomeni che fanno la storia di una società: economia, rapporti sociali, ceto politico, fenomeni culturali, trame criminali etc. Il lettore ha così la possibilità di avere una visione dei processi e degli eventi che hanno segnato questa parte d’Italia e la consegnano oggi al nostro presente con le sue luci e le sue ombre, le sue lacerazioni e le sue potenzialità. Un vasto territorio in cui comunque si specchiano, esasperati, i caratteri di un Paese gravemente malgovernato e in declino. Questa Storia costituisce pertanto un invito a ripensare il nostro Sud come parte di un progetto di rinascita politica e culturale dell’Italia tutta.
Filippo Veltri
Giornalista, saggista, socio ICSAIC